Relatrice Tiziana Colusso, scrittrice, la quale ha toccato punti importanti e fondamentali per la comprensione del romanzo.
Ecco i suoi appunti sulla relazione
Luciana Gravina “Ginestre e libri proibiti”, Onereededizioni, Milano, 2016
Luciana Gravina “Ginestre e libri proibiti”, Onereededizioni, Milano, 2016
La vicenda in parte vera e in
parte verosimile narrata di Luciana Gravina è ambientata nel Cilento, una terra
aspra al confine tra Campania e Lucania, dove le vicende umane sono
incorniciate ma anche tenute a bada da
una natura più che presente.
La natura – con i suoi ritmi irriducibili e irresistibili – è rappresentata
dai fiori profumatissimi ed eclatanti della Ginestra, fiore tra l’altro di
forte ascendenza leopardiana. Come nel poemetto Leopardiano, la natura
(simboleggiata dalla testarda resistente ginestra) resiste al tempo e alle
catastrofi, e al crollo delle civiltà.
Così, dell'uomo ignara e dell'etadi/ Ch'ei chiama antiche, e del seguir
che fanno /Dopo gli avi i nepoti, /Sta natura ognor verde, anzi procede /Per sì
lungo cammino, /Che sembra star. Caggiono i regni intanto, /Passan genti e
linguaggi: ella nol vede: / E l'uom d'eternità s'arroga il vanto. (G.L)
Questa tonalità leopardiana,
insieme dolente e “panica” , nel senso di sentimento panico della natura,
un’empatia profonda e quasi una fusione che va al di là delle metafore per
diventare quasi uno slittamento intuitivo tra il sentire umano e vegetale.
Del resto le recenti scoperte
della “neurobioogia vegetale” sembrano confermare la presenza di
un’intelligenza vegetale, certo non intelligenza nel senso umano del termine,
ma nel profondo senso di empatia collettiva e risposta ai ritmi della vita e
dei fenomeni cosmici.
All’interno di questo quadro
naturale, le vicende degli uomini si dipanano in una narrazione densa e tesa,
ambientata nel Seicento, secolo fecondo di idee ma anche caratterizzato da una
forte repressione, soprattutto da parte del’Inquisizione, strumento di una
Chiesa che mal tollerava i pensatori liberi e nuovi che iniziavano a mettere le
basi del pensiero moderno: a partire da Galileo Galilei, vissuto a cavallo tra
500 e 600, uno dei padri fondatori della scienza e della filosofia moderne. Il
libro narra anche dei libri dei mistici e degli eretici, e dei movimenti religiosi
considerati eversivi, come quelli del Cristianesimo pauperista o del movimento
essenico.
Ma il libro di Luciana Gravina
non è un trattato, e riesce a far piacevolmente filtrare tutto questo
tormentato sommovimento spirituale e
culturale attraverso una narrazione piacevole e piena di colpi di scena,
incentrata sul percorso diremmo oggi “di consapevolezza” di un prelato intellettuale
di campagna, don Biagio Gravina, personaggio fittizio che l’autrice immagina essere
un suo lontano avo.
Attorno a Don Biagio, gravitano
come pianeti di un complicato universo, sia personaggi storici che personaggi inventati:
sono personaggi storici (come la stessa autrice sottolinea in una nota finale) i
vari alti cardinali e funzionari della Chiesa conservatrice e repressiva dell’epoca,
così come sull’altro versante la Regina Cristina di Svezia, sovrana illuminata
e protettrice di pensatori al limite dell’eresia e dei loro “libri proibiti” e
messi all’Indice dall’Inquisizione. Gli altri sono personaggi inventati da verosimili
e convincenti, come la “peccatrice” Filomena,
una Maddalena di paese.
La sfida di un romanzo insieme storico, filosofico e
in qualche modo etnografico (il ritratto di tutto un habitat tra i paesi del
Cilento.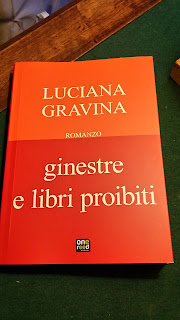
Nessun commento:
Posta un commento